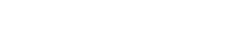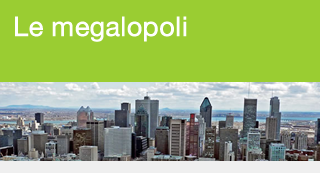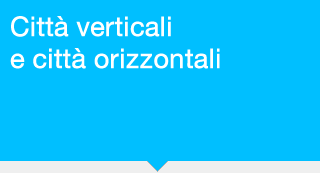Dalla fine dell’Ottocento e soprattutto negli ultimi decenni, l’espansione delle città ha seguito strade diverse:
- foreste di altissimi grattacieli (skyscraper), con una grande densità di utenti;
- enormi sobborghi diffusi sul territorio, fenomeno chiamato “dispersione urbana” (urban sprawl) e caratterizzato da una bassa densità di abitanti.
Il primo grattacielo è sorto a Chicago verso la fine dell’Ottocento; oggi tutte le metropoli statunitensi sono caratterizzate da spettacolari skyline. Usati per lo più come sedi di uffici, i grattacieli americani caratterizzano in particolare i cosiddetti CBD (Central Business Districts), cioè i quartieri dedicati alle attività economiche terziarie.
Il primo grattacielo costruito in Italia è la Torre della Vittoria di Brescia, completato nel 1932. In Europa, lo sviluppo in verticale è avvenuto soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, ma ha riguardato un numero abbastanza ristretto di grandi città come Londra, Parigi ecc.
Oggi la tendenza a costruire grattacieli è presente soprattutto nei Paesi emergenti, come la Cina e gli altri asiatici, dove ne sorgono centinaia all’anno: qui si è affermato anche il grattacielo a uso residenziale, mentre altrove prevale l’utilizzo come sede di uffici. Tra i primi dieci grattacieli più alti del mondo, nove sono asiatici.
Il fenomeno della dispersione urbana, con le città che si allargano a macchia d’olio e in modo disordinato sul territorio circostante, è diventato massiccio dalla seconda metà del Novecento grazie alla diffusione di diversi strumenti di comunicazione, come l’automobile e il telefono.
Questo tipo di urbanizzazione è presente dappertutto, in Italia come in Europa e negli altri continenti. Uno dei più famosi esempi di “città diffusa” si trova negli Stati Uniti: è Los Angeles, il cui territorio urbano è grande come l’intera provincia di Milano.
Secondo i sostenitori del modello verticale i vantaggi dei grattacieli sono: minore consumo di suolo, possibilità di avere o conservare grandi spazi verdi, riduzione del traffico privato, che nelle città diffuse è invece molto elevato, possibilità di ospitare un numero sempre maggiore di abitanti.
Secondo i critici delle città verticali, questi ambienti rendono disumano il paesaggio urbano, rendono più difficili le relazioni sociali e quelle che ogni persona ha con il territorio in cui vive e lavora; inoltre gli edifici disegnano un paesaggio anonimo di vetro, cemento e acciaio, spesso privo di collegamenti con la cultura, le tradizioni e i materiali locali.