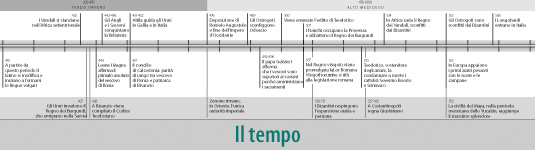| |
|
 |
 |
 |
 |
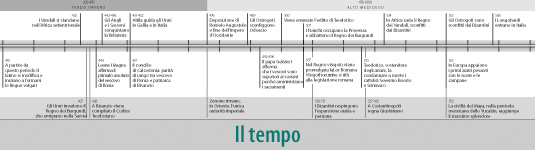 |
 |
 |
per scaricare tutti i documenti |
 |
 |
|
 |
 |
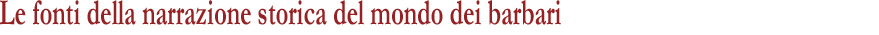 |
 |
 |
 |
Le fonti per lo studio della storia del mondo dei barbari |
| |
Sull’universo dei Germani abbiamo, innanzitutto, l’opera di Giulio Cesare, De bello Gallico, in cui il condottiero dimostra un notevole piglio di scrittore, descrivendo gli usi e i costumi delle varie tribù che popolavano la Gallia. Certo, Cesare dà la precedenza all’aspetto militare e tende spesso a esagerare nel descrivere la potenza delle tribù per far risaltare maggiormente la sua abilità e il valore dei suoi uomini, ma il ritratto che emerge è efficace.
Lo storico romano Tacito, scrivendo all'epoca di Traiano (intorno al 98 d.C.), tracciò dei Germani occidentali un quadro più notevole forse per intento morale che per fedeltà oggettiva. Scopo dello storico romano era porre a contrasto l'idealizzata semplicità della vita dei Germani con il lusso degenerato della società italiana e trovare nei liberi costumi dei nobili selvaggi, argomenti per condannare gli uomini civili.
Tacito aveva giustamente intuito che i Germani erano in grado di dare alla civiltà europea nuovi importanti valori: aveva visto in questi barbari una fresca forza di rinnovamento, e compreso com'essi possedessero ormai il segreto della libertà politica, che Roma aveva dimenticato, la passione per l'iniziativa individuale, che Roma aveva soffocato, l'abitudine di allevare famiglie numerose, che Roma ormai trascurava e disprezzava. L’ultima di queste caratteristiche diede ai Germani una superiorità decisiva nelle lotte contro il mondo latino.
Per quanto concerne il V secolo d.C. le fonti letterarie vengono sia dal mondo pagano che da quello cristiano. Tra i pagani acquista una certa fama Zosimo che nel VI secolo scrive in greco in sei libri la Storia Nuova, che va dalle origini di Roma al 410 d.C. Non ha la levatura di Ammiano Marcellino ma la sua opera è interessante perché attinge largamente al testo dell’opera di Eunapio di Sardi, uno storico pagano suo contemporaneo che predicava lo scontro fisico tra cristiani e pagani.
In campo cristiano la storiografia è rappresentata da Orosio, un sacerdote spagnolo che nel 417 compone 7 libri di Storie contro i pagani: si tratta di un’opera composta in chiave violentemente polemica contro i pagani e che interpreta, deformandola, tutta la storia di Roma in funzione della Provvidenza Divina.
Dopo la metà del V secolo d.C., con il crollo delle strutture dell’Impero romano di Occidente, si afferma il genere della “cronografia”: in sostanza, molte comunità registrano anno per anno tutti gli eventi più importanti, in forma di brevi annotazioni e senza alcun commento o interpretazione.
Più interessante, invece, è il panorama delle opere che descrivono le caratteristiche dei vari popoli barbari che cominciano a penetrare oltre la frontiera romana. Famosa era la descrizione dei Goti fatta da Cassiodoro, oggi andata perduta, mentre possediamo una Storia dei Britanni anonima, una Storia dei Franchi di Gregorio di Tours e molte altre opere analoghe.
Come i barbari si comportarono nei confronti delle istituzioni romane
Teodorico
Il passaggio dal latino al volgare
|
 |
| |
Il Cristianesimo come fattore di trasformazione della lingua |
| |
Il Cristianesimo non solo rivoluzionò la concezione dell’uomo e della storia e determinò mutamenti radicali nella cultura, ma ebbe anche importanti influenze sulla lingua. Fino al II secolo d.C.,anche in Occidente, la lingua della Chiesa era stata il greco : nel momento dell’espansione delle strutture ecclesiali venne adottato il latino e questo comportò una consistente immissione di termini greci, in quanto dovette usare termini prima sconosciuti alla cultura latina. Ad esempio “Ecclesia” originariamente indicava la comunità dei fedeli e poi passò a significare l’edificio del culto, la chiesa, “baptizare” dal greco baptìzo che significa immergere, monacus dal greco monos cioè solo, Cristus dal greco “unto del Signore, prescelto”. Molte parole latine si piegarono ad indicare concetti del tutto nuovi come peccare (originariamente “sbagliare”) che poi significò infrangere norme religiose e morali.
L’influenza del Cristianesimo investì anche lo stile e rovesciò il concetto classico della necessità di adeguare la lingua all’argomento trattato: ora,infatti, quello che importa è solo il contenuto di verità del testo scritto o orale e non l’eleganza delle parole. L’esigenza primaria è che il pubblico capisca il significato del messaggio.
Il latino così conservato divenne uno strumento di affermazione sociale e culturale, conosciuto dal clero e da pochi grandi signori laici. A partire dalla fine del VI secolo pochissimi sanno leggere e scrivere e lo stesso Vangelo dal VII secolo diventa una testo riservato a pochi. |
| |
| |
Le fonti per lo studio dell’Alto Medioevo |
| |
La parola “Medioevo”, ossia “età di mezzo”, utilizzata per la prima volta nel XV secolo, si diffuse poi fra gli intellettuali del Quattro-Cinquecento, per indicare un lungo periodo della storia percepito come qualcosa di nettamente diverso sia dall’antichità classica sia dalla nuova età alla quale essi sentivano di appartenere.
Questi intellettuali, gli umanisti, volevano ricollegarsi idealmente alla grande civiltà greco-latina, e pensavano al proprio tempo come a un’epoca di “rinascita” dei valori di quella civiltà. Di conseguenza, avevano un’idea negativa dell’epoca medievale: la consideravano come un intervallo di secoli bui, un’età di imbarbarimento rispetto agli splendori dell’età classica precedente e ai successivi trionfi dell’età della rinascita.
Verso la metà del XVI secolo, la polemica contro l’età medievale iniziata dagli umanisti fu ripresa dagli scrittori che aderirono alla Riforma protestante avviata da Lutero. In quei secoli, essi vedevano la decadenza degli ideali e della purezza evangelica originaria del Cristianesimo, a causa dell’avidità di beni materiali e di potere da parte della Chiesa.
Tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, molti intellettuali che possiamo ricondurre al movimento culturale del Romanticismo fecero l’operazione opposta: rivalutarono pienamente e anzi sopravvalutarono il Medioevo. Le ragioni di questo ribaltamento di giudizio furono molteplici. Ricordiamo soltanto che in quel periodo diversi popoli europei lottavano per l’indipendenza e ricercavano le proprie origini nazionali, che affondavano le radici appunto nel Medioevo.
Oggi, il giudizio sul Medioevo è profondamente cambiato. Si trattò certo di secoli in cui il Cristianesimo produsse una drastica svalutazione della vita terrena, vista come fonte di peccato e di perdizione. Ma l’indagine storica ha messo in luce anche aspetti positivi e progressi in ogni settore. Un autorevole studioso del Medioevo come Jacques Le Goff ha sottolineato gli elementi di continuità tra Medioevo ed Età moderna: non si trattò né di un vuoto né di secoli bui, ma di un periodo che, pur fra crisi, arresti e temporanei regressi, espresse nel complesso una spinta creatrice, determinante per i successivi processi di sviluppo dell’Età moderna.
Il concetto moderno di Medioevo
La differenza tra la realtà medievale e quella moderna
La religiosità all’inizio dell’Alto Medioevo
Come si leggono i testi della classicità. L’incontro-scontro tra la Chiesa e il mondo classico
La superstizione nell’Alto Medioevo
|
| |
|
|
 |
| © 2010 DeAgostini Scuola S.p.A. - Novara |
|
|
|