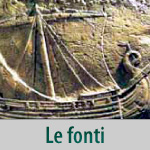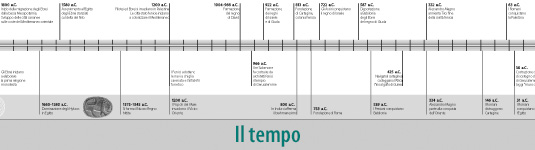| |
|
 |
 |
 |
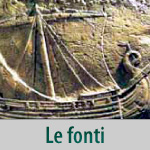 |
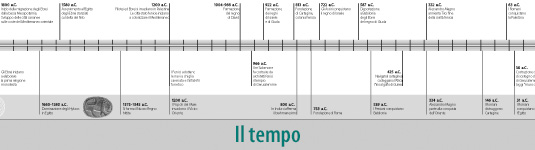 |
 |
 |
per scaricare tutti i documenti |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le fonti storiche |
| |
Una grande quantità di notizie sulle vicende storiche degli antichi Ebrei ci viene dagli archivi dei palazzi reali di Assiri, Babilonesi ed Egiziani. In molte tavolette d’argilla troviamo precisi riferimenti ai contatti che queste popolazioni hanno avuto con gli Ebrei e sulla base di queste indicazioni si è potuta ricostruire una cronologia attendibile.
Minuziose sono le cronache dei re assiri Salmanassar III, Tiglatpileser III e Sargon che descrivono le spedizioni militari contro i re d’Israele e i tributi che questi si assoggettarono a pagare. Famosa è poi la stele egiziana detta d’Israele, del 1230 a.C., che parla diffusamente della presenza degli Ebrei in Egitto.
La fonte principale, però, della storia antica degli Ebrei è la Bibbia, un documento che ha assunto un’importanza fondamentale sia sul piano religioso che su quello politico e storico, e non solo per il popolo ebraico. |
 |
| |
Le fonti materiali |
| |
Purtroppo i Fenici hanno lasciato solo tracce poco significative della loro storia, soprattutto a causa dell’accanirsi dei nemici contro i loro edifici. Tuttavia sappiamo, da numerose testimonianze, che erano abili costruttori.
Gli antichi Ebrei obbedivano al comandamento biblico che vieta di riprodurre l’immagine di qualsiasi creatura vivente. Per questo motivo, l’arte ebraica antica si distinse soprattutto nell’architettura, anche se il precetto della Bibbia venne spesso ignorato, almeno a partire dal III secolo d.C.
In campo architettonico dobbiamo citare, innanzitutto, il tempio fatto innalzare da Salomone a Gerusalemme che incontrò terribili vicissitudini tra distruzioni e ricostruzioni ma che intuiamo, dalle testimonianze in nostro possesso, essere stato grandioso e splendido nelle decorazioni.
Altro settore interessante, in campo architettonico, sono le Sinagoghe, luogo di raccolta per la preghiera ma anche per lo studio. Quelle più antiche erano, in genere, a tre navate: sopra le navate laterali c’era il matroneo, il luogo, cioè, dal quale le donne assistevano alle funzioni e attorno alle pareti correvano decorazioni e spesso mosaici.
Scarsi resti architettonici, però, sono giunti fino a noi: misere rovine dei palazzi reali e qualche tomba dei profeti. Dell’unico tempio che avevano, per quanto grandioso, resta in piedi solo un muro – il Muro del Pianto – di grande importanza simbolica, ma insignificante dal punto di vista architettonico.
|
 |
| |
Le fonti scritte |
| |
A lungo si è dibattuto, e ancora si dibatte sulla storicità degli eventi narrati nella Bibbia. La maggior parte degli storici sono giunti alla conclusione che la storicità del testo biblico inizia con l’Età dei Re, mentre gli eventi precedenti a questa data sono poco credibili storicamente.
Il problema della storicità del racconto biblico ha coinvolto molti studiosi. Nel XVIII secolo gli Illuministi, che intendevano sottoporre ogni argomento al rigoroso vaglio della ragione, liquidarono la Bibbia come una raccolta di miti, leggende e racconti privi di riferimenti storici.
Questo atteggiamento continuò anche nel XIX secolo: molti studiosi continuarono a leggere l’Antico Testamento come l’espressione di un mondo a sé stante, non legato ad alcun contesto storico particolare. Con lo svilupparsi dell’archeologia scientifica, da un lato, e con la progressiva conoscenza dei contenuti delle tavolette assire, babilonesi e persiane, ha cominciato a delinearsi un quadro storico più nitido, in cui molti riferimenti contenuti nella Bibbia trovavano precisi riscontri.
Oggi siamo arrivati a concludere che i libri storici della Bibbia, quelli cioè che narrano dal periodo dei re in avanti, parlano di un mondo reale, storico.
Qui le schiere degli studiosi si dividono nettamente tra chi è convinto che esistano, anche in questo caso, riscontri inoppugnabili dalle scoperte archeologiche e chi, invece, si mostra più scettico o incerto dinnanzi a racconti difficilmente collocabili in un preciso periodo storico.
Nella lettura La Bibbia aveva ragione, riportiamo un passo dell’introduzione all’opera omonima di Werner Keller, uno scienziato divulgatore che, a differenza di tanti suoi colleghi, non ha alcun dubbio sulla storicità di ogni pagina della Bibbia. |
 |
 |
Le fonti letterarie |
| |
Della letteratura fenicia abbiamo solo notizie indirette e un gran numero di iscrizioni votive, commemorative e funerarie. Sappiamo da fonti indirette che i Fenici produssero molte opere, distinte in veri e propri generi letterari come annali, liturgie, testi sapienzali, economici ed epistolari.
È rimasta famosa la relazione di viaggio del navigatore Annone che nel 425 a.C. circa, partendo da Cartagine, avrebbe costeggiato l’Africa, passando dallo Stretto di Gibilterra (le Colonne d’Ercole) e arrivando fino al Golfo di Guinea. Al ritorno avrebbe fatto incidere il racconto del suo viaggio su una stele nel tempio del dio Cronos (il fenicio Baal Hammon). A noi è giunta una parte di questa relazione in lingua greca.
Le iscrizioni rinvenute in Fenicia e nelle diverse colonie sono numerosissime ma offrono ben poco allo storico per quanto riguarda la conoscenza di questo popolo. Innanzitutto in molte di queste iscrizioni non si è riusciti a tradurre completamente il testo e, in secondo luogo, i testi tradotti sono elenchi di cariche pubbliche, preghiere, documenti contabili, perciò nulla di particolarmente interessante per una indagine storica.
Il capolavoro della letteratura ebraica antica resta senza dubbio la Bibbia. In essa, a parte la componente religiosa, troviamo delicate poesie, descrizioni vivissime di eventi e potenti immagini di uomini e donne. Proponiamo alcuni passi famosi.
Nel documento Storie dalla Genesi e dall’Esodo troviamo il brano L’alleanza (Genesi, 17, 1-11) riportiamo il passo della Genesi che narra di Abramo e del suo trasferimento da Ur, città della Caldea, nella terra di Canaan. Qui venne stipulato un patto dall’alleanza tra Dio e gli Ebrei, che da allora furono il popolo eletto. In questo passo della Bibbia Abramo ha ormai novantanove anni e Dio gli conferma il patto d’alleanza.
Mentre il brano Si aprono le acque del Mar Rosso (Esodo 15,15-30) è la descrizione, estremamente realistica, della fuga degli Ebrei attraverso le acque del Mar Rosso che Dio aveva miracolosamente aperto. Le acque, poi, si richiuderanno sull’esercito egiziano che li inseguiva. Questo evento è rappresentato dal regista Cecil B. De Mille nel film I dieci comandamenti con effetti speciali veramente incredibili per gli anni ’50.
Il canto di Debora (Giudici 5, 1-32) è il canto con cui Debora, giudice d’Israele nel periodo precedente all’età dei Re, celebra la vittoria su Sisera, generale del re cananeo Yabin. Il canto ha una vera struttura narrativa, che si snoda in diversi momenti: la paura e l’impreparazione di Israele davanti al nemico, la chiamata in campo di Debora, la battaglia, la morte di Misera, la vana attesa di sua madre.
Nel documento La vanità e la vita abbiamo raccolto altri due passi della Bibbia. Il primo passo Vanitas vanitatum ed omnia vanitas (Ecclesiaste 1, 1-11) è universalmente noto ed è un capolavoro nel genere della poesia sapienziale. Tutte le cose umane sono vane, destinate a ripetersi senza scopo e anche la sapienza accresce il dolore dell’uomo, perché gli dà la coscienza della propria nullità e della mancanza di significato della sua vita. È un testo scritto in epoca tarda, sotto la palese influenza della filosofia greca, ma la chiusura stravolge tutto: il senso della vita umana sta nel temere Dio e osservare i suoi comandamenti. La pochezza della vita (Giobbe 14, 1-22 e 28, 12-16) è, invece, una lamentazione e in esso viene trattato un tema già presente ampiamente nelle letterature della Mesopotamia e dell’Egitto e ripreso poi dai Greci e dai Romani. È la desolata constatazione che i dolori della vita non dipendono necessariamente da una colpa commessa, perché la vita stessa, nella sua brevità e insensatezza, rende infelice l’uomo.
Sotto il titolo La punizione abbiamo raccolto un esempio di letteratura profetica e un esempio di poesia messianica La punizione di Dio su Israele (Sofonia 1, 14-18) è un esempio di letteratura profetica. Sofonia, un profeta minore, ha la visione della punizione che Dio infliggerà ad Israele e a tutti gli uomini per i loro peccati. Dopo la punizione tornerà un’età felice (Isaia, 11, 1-9) ci racconta che dopo la punizione inflitta a Israele e a tutti gli uomini per i loro peccati tornerà un’età felice dominata dalla figura del Messia che nascerà dalla stirpe di Davide. È questo un esempio di letteratura messianica che descrive una sorta di età dell’oro, un ritorno al Paradiso terrestre, in cui uomini e animali vivevano in pace e serenità.
Il Cantico dei Cantici (Cantico dei Cantici 1-8) è una poesia famosissima, in cui viene celebrato l’amore in tutti i suoi aspetti, compreso quello fisico tra un pastore e una pastorella. È un testo universale in cui si riconoscono gli uomini e le donne di ogni epoca.
|
 |
 |
Le fonti giuridiche |
| |
Per quanto ne sappiamo i Fenici non possedevano codici di leggi, come il Codice di Hammurabi. L’amministrazione della giustizia spettava al re che delegava quasi sempre questo compito ai magistrati della città-stato o ai sacerdoti, a seconda della tipologia del delitto.
Sull’amministrazione della giustizia abbiamo notizie abbastanza precise per quanto riguarda Cartagine. In questa città la giustizia era nelle mani dei Sufeti: per i delitti più gravi il compito passava a un Consiglio di 100 (o 104) senatori che restavano in carica tutta la vita e con poteri piuttosto estesi.
Pochissimo è rimasto dei testi giuridici degli Antichi Ebrei. Sappiamo comunque che il testo giuridico per eccellenza erano i comandamenti dettati da Dio a Mosè.
In sostanza, erano i sacerdoti a giudicare i delitti più gravi, specialmente quelli che offendevano JHWH (“io sono quel che sono”, cioè Dio) o ne mettevano in dubbio l’esistenza. Per i delitti comuni erano chiamati a giudicare gli anziani dei villaggi o, a seconda della gravità, i funzionari del re che reggevano i distretti. Non esistevano codici di leggi, perché l’unica Legge era quella divina, trasmessa da JHWH a Mosè.
|
 |
 |
Le fonti indirette |
| |
Abbiamo numerosissime testimonianze sui Fenici, sia per quanto riguarda la loro attività politica e commerciale, sia per quanto riguarda il comportamento e la loro morale. I giudizi sono discordanti e spesso dettati da preconcetti. Esploriamo una serie di questi punti di vista contraddittori nel documento Le fonti indirette della storia della civiltà dei Fenici. |
 |
| |
|
|
 |
| © 2010 DeAgostini Scuola S.p.A. - Novara |
|
|
|